L’alberghiero non è una scuola di serie B: è l’unica che forma per uno dei primi settori economici del nostro Paese. Ma diciamolo senza ipocrisie: in Italia il figlio “bravo” in genere non va all’alberghiero. Non perché l’ospitalità non offra lavoro, carriera o prospettive internazionali, ma perché continua a pesare un riflesso culturale durissimo a morire. Il professionale resta, infatti, nell’immaginario collettivo, il piano di riserva per chi “non è portato” per altro. Un pregiudizio che resiste al valore e peso reale che turismo e ristorazione hanno nell’economia del Paese. E che oggi presenta un conto salato: scuole svuotate, personale che manca (soprattutto nella sala, oltre che in cucina), vocazioni che arrivano tardi o non arrivano affatto.
Liceizzazione e perdita di attrattività: un problema di percezione
Un riflesso che si è rafforzato negli ultimi anni dentro una liceizzazione quasi totale del sistema scolastico, che ha progressivamente spostato aspirazioni e aspettative verso questi istituti, anche quando non rispondono davvero alle inclinazioni degli studenti. E il risultato è misurabile negli ultimi dati. Basti pensare che le preferenze per gli istituti alberghieri sono crollate dal 9,2% dell’anno scolastico 2014/15 al 3,94% del 2025/26, segnando una perdita di attrattività che non può essere spiegata solamente con il calo demografico. È un dato che racconta un problema di percezione prima ancora che di offerta formativa, e che anticipa le difficoltà che oggi l’intero comparto vive sul piano del personale, delle competenze e del ricambio generazionale.

Le preferenze per gli alberghieri sono crollate dal 9,2% dell’anno scolastico 2014/15 al 3,94% del 2025/26
Perché cambiare nome non è un’operazione “cosmetica”
Da qui nasce anche una proposta - che Italia a Tavola ha già avanzato - e che da sola non basta, ma può essere parte della soluzione: cambiare il nome dell’alberghiero, smettere di chiamarlo “professionale” e iniziare a parlare di “liceo dell’accoglienza” (così come accade in Francia con il Lycée Hôtelier, in italiano liceo dell’hotellerie). Non per un’operazione puramente cosmetica, diciamo, ma per riallineare il linguaggio alla realtà di percorsi che richiedono studio, competenze trasversali, capacità gestionali, cultura del servizio e visione internazionale. Perché finché continuiamo a usare parole che evocano un’idea di ripiego, sarà difficile scardinare una percezione che produce scelte difensive invece che vocazioni.
Orientamento sbagliato e vocazioni rimandate
È da questo nodo - prima culturale che scolastico - che si innestano poi tutte le criticità di oggi: il calo delle iscrizioni, lo squilibrio fra cucina e sala, la difficoltà a reperire personale formato e motivato. E anche le riflessioni di Carla Parolari, preside dell’Istituto professionale per i servizi per enogastronomia ed ospitalità alberghiera “Vincenzo Gioberti” di Roma, partono da qui, da una filiera dell’orientamento (alle medie) che ha raccontato male l’ospitalità e che oggi presenta il conto a scuole e imprese. «Nell’accezione italiana il professionale resta una scuola che non è di serie A. E questo porta l’italiano a mandare malvolentieri un ragazzo con risultati brillanti all’istituto alberghiero». Una percezione che, aggiunge Parolari, finisce per frenare proprio quelle vocazioni più forti e consapevoli: «Se questo percorso avesse un riconoscimento anche solo simbolicamente più “liceale”, probabilmente ci sarebbe meno paura ad affrontarlo, soprattutto in una prospettiva internazionale».
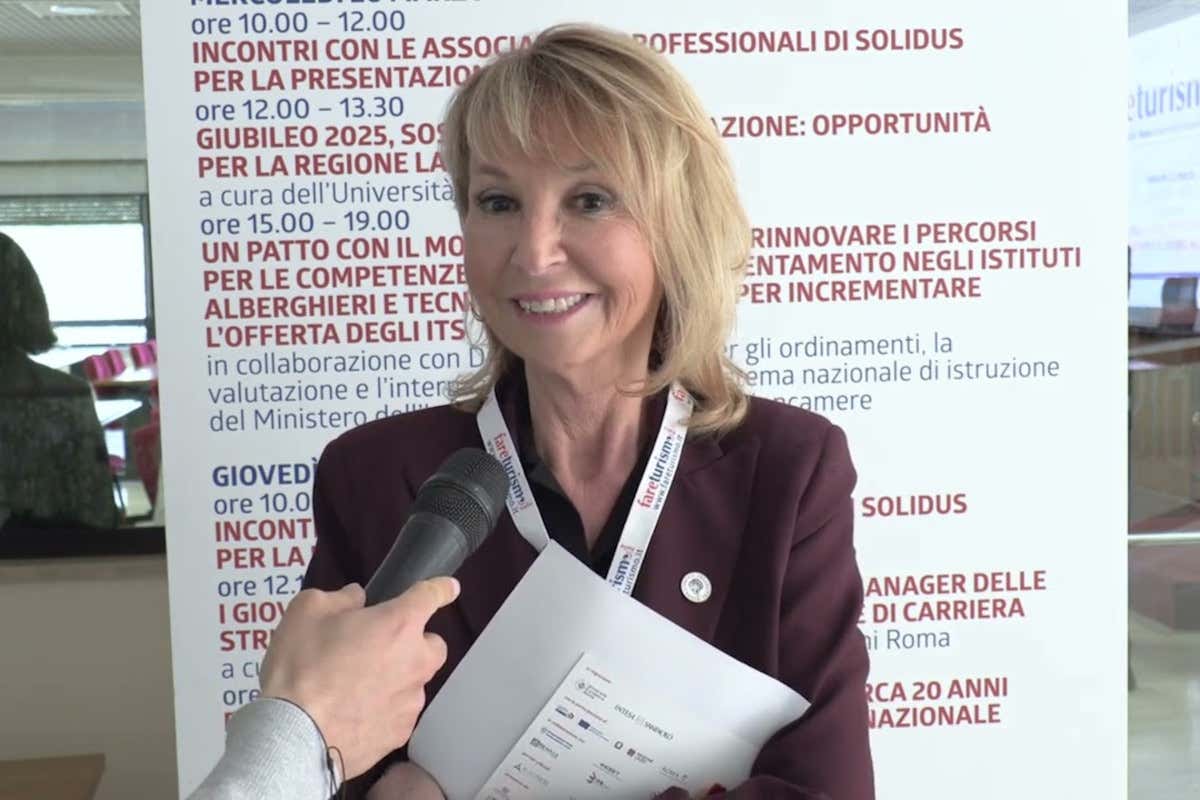
Carla Parolari, preside del “Vincenzo Gioberti” di Roma (credits: FareTurismo/YouTube)
Una diffidenza che produce effetti concreti anche sui percorsi successivi. Perché quei ragazzi “bravi” che non vengono incoraggiati a scegliere l’alberghiero spesso non rinunciano all’ospitalità, ma ci arrivano più tardi, passando da strade diverse. Lo dimostra, osserva Parolari, ciò che accade nei percorsi di alta formazione: «Altrimenti non si spiegherebbe perché all’Alma arrivino tanti studenti che non provengono dagli istituti alberghieri, ma da licei o addirittura dall’università». Tra i corsisti, aggiunge, ci sono molti laureati, così come nel mondo del vino: «Quanti sommelier oggi sono laureati? Tantissimi». Un segnale evidente di vocazioni rimandate, più che mancate: studenti che scelgono prima percorsi ritenuti più “sicuri” dal punto di vista culturale e sociale, per poi tornare all’ospitalità quando l’interesse diventa troppo forte per essere ignorato.
La sala e il racconto mancante dell’ospitalità
Un altro punto centrale, secondo Parolari, riguarda il modo in cui viene raccontato il mondo del lavoro nell’accoglienza, soprattutto in quello della sala (tema su cui Italia a Tavola si sta battendo da tempo). Non tanto per ciò che è, quanto per ciò che non viene detto. «Spesso non passa il messaggio che questa professione offra prospettive di carriera molto interessanti», osserva, soprattutto all’interno di strutture organizzate e di alto livello, comprese le grandi catene alberghiere internazionali. Un vuoto narrativo che contribuisce a consolidare l’idea della sala come scelta di ripiego, anziché come professione strutturata e in grado di offrire crescita. Eppure, le opportunità esistono, e sono vere, concrete. Dal Gioberti, racconta Parolari, sono usciti studenti oggi inseriti in contesti di rilievo, dalla ristorazione di alto profilo a grandi strutture alberghiere, fino a ruoli legati alla formazione e ad ambiti istituzionali. Percorsi che dimostrano come la sala possa essere una porta d’accesso a carriere solide, anche internazionali, e non un semplice passaggio temporaneo.

Spesso non passa il messaggio che i mestieri dell'accoglienza offrano prospettive di carriera interessanti
Il problema, semmai, è che questa dimensione non viene raccontata abbastanza, né ai ragazzi né alle famiglie. A pesare, come detto, è ancora una narrazione riduttiva, che fatica a riconoscere il valore professionale del servizio e continua a legarlo a un’immagine statica, poco attrattiva. «Sembra che la carriera in sala sia ancora associata alla figura del cameriere», osserva Parolari, mentre in realtà il lavoro oggi richiede competenze complesse, capacità relazionali, gestionali e una visione ampia dell’ospitalità. Da qui l’esigenza di un cambio di passo nel racconto. «Forse bisognerebbe iniziare a parlarne in positivo, come è successo per gli chef». Rendere visibili le carriere, i ruoli, le possibilità di crescita significa restituire dignità e attrattività a una professione che, nei fatti, offre molto più di quanto venga comunemente percepito.
Ma il cambio di nome non basta senza tutele e riconoscimento
Secondo Parolari, però, sarebbe sbagliato pensare che tutto si risolva solo cambiando il racconto o l’orientamento scolastico. «I fattori sono tanti, a partire dai contratti», dice, perché le condizioni di lavoro incidono in modo diretto sulle scelte di vita e di carriera. È anche per questo che la proposta di ripensare l’alberghiero come un “liceo dell’accoglienza” può avere senso: perché prova a intervenire su un blocco culturale profondo. Ma perché non resti solo un’operazione simbolica, deve essere accompagnata da un riconoscimento concreto della professione. Senza tutele, contratti credibili e possibilità di crescita reali, nessun cambio di nome potrà invertire davvero la rotta.